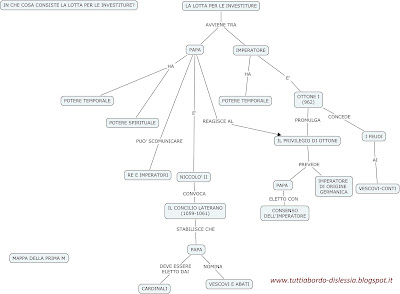Pubblichiamo, ringraziando autore e testata, un racconto apparso sul numero tre di The Flr – The Florentine Literary Review. L’argomento del numero è il sacro.
Dio è Donna.
(Sintesi di una chiacchierata tra Albino Luciani e Patti Smith)
p.s. We sincerely apologize to all Platypus enthusiasts out there who are offended by that thoughtless comment about the Platypi.
We at View Askew respect the noble Platypus, and it is not our intention to slight these stupid creatures in any way.
Thank you again and enjoy the show.
(Kevin, Smith)
Quello che voleva, era sentirsi dire da Lei che non aveva amato mai nessuno come lui. Soprattutto, pensava ora, voleva sentirsi dire da Lei che lui era, in assoluto, l’uomo della sua vita; almeno in questa prospettiva: in quest’incarnazione vaga che le parole cercavano per potersi definire esattamente.
Per Lei era stato un problema non dappoco, affrontare il suo desiderio incrociandolo con quello che riusciva a capire: comprendere la richiesta senza nemmeno avere chiaro cosa fosse un ‘uomo della sua vita’.
Del resto non poteva che essere così, si dice Dio adesso, fluttuando a mezzavìa tra la Costellazione di Pegaso e l’equatore fittizio della Galassia Nascosta di Althazar. Scalcia nei sàndali che ha progettato per un ipotetico Figlio lontano rotoli e rotoli di stelle fisse che – a balzelloni, scardinando la complicità delle intuizioni quantistiche – precìpitano nei buchi neri di passaggio lasciandosi inghiottire, esauste, dopo corse cieche di miliardi di anni.
Troppo impreciso con la terminologia, probabilmente. Uomo, vita. Lei ne era rimasta incuriosita, all’inizio, lasciandosi portare da quella follìa infuocata fatta di presagi e durate, certezza incrollabile del futuro e – intanto – somma di tempi sparsi che si andavano affacciando dagl’interstizi collosi dell’Eternità sottoforma di fosfeni polverosi; quasi la scoperta di un nuovo vocabolario avesse coinciso con l’apertura, scricchiolante, di una scrivania grande quanto la Via Lattea; uno scrittoio in legno che si spalanca scoperchiando pagine e pagine fittissime di profezie. E – intanto – spezza il coperchio in due assecondando una crepa rumorosa che si spalanca sull’abisso. E si spacca; rinfrancàndosi nello scatto cigolante di una risata a forma di orizzonte degli eventi.
Troppe parole. Troppe. Questa fissazione che l’inizio, quindi tutto, dipenda da una parola dietro l’altra che si rincorrono e s’inseguono senza trovare mai requie e quiete. Quando in realtà tutto era già stato detto prima di parlare.
Si concentra su un’esplosione raggiante di elio che gli strozza la gola e la voce. L’ultima volta che ha parlato con sé stesso il suono gli ha spaccato il timpano sinistro (quello che ascolta le lamentazioni eterne del suo lato oscuro); s’era dimenticato dell’assolutezza insostenibile della Voce di Dio: talmente piena di Sé, e stonata, da spazzare via costellazioni e sistemi solari solo con il suono aspro e secco di una velare.
L’esplosione assoluta, e aperta, della prima labiale. Una lettera; e l’inizio assordante e meraviglioso di ogni Universo.
Le sue stesse parole l’avevano reso sordo da un orecchio. Confidava nelle possibilità riconciliàbili dei suoi recuperi, per rilanciarsi finalmente fine ascoltatore delle parole di Lei: di quelle che gli aveva lasciato a sbiadirsi e rinfrancarsi – nel giro di un’ora, magari; o di un minuto eterno quanto tutto il presente – piene di dubbi e di paure che galleggiavano, stordite, sul filo di ghiaccio incandescente della sua scelta.
Per non pensare, si dice Dio, dovrei mettermi all’Opera. Così decide di creare un Universo aggiunto fondato sulle leggi dell’entropia. Il terzo, nell’ultimo semestre. Il penultimo gli aveva occupato tutto il tempo che ci vuole per passare dall’IH del primo Universo all’IHV del quintesimante dell’Universo precedente. Avrebbe dovuto uniformare le unità di misura numeriche per il còmputo degli Universi in fabbricazione, prima o poi. Non si può catalogare nulla senza una grammatica numerica condivisa. Se ne accorgeva ogni volta che tentava di chiarirsi la concatenazione degli eventi che creava volta per volta.
Solo, si sentiva. Troppo solo per non continuare a mostrarsi Dio.
Per non pensare, èccolo: ora si mette a lavorare, con precisione, all’ultimo progetto sùbito edificato in una sottospecie di eternità minuscola e fittizia. Si lascia distrarre, per qualche minimo secondo di fortuna, dalle nuove gradazioni di rosso che ha appena pensato. Un’ondulazione granulosa dal carminio allo scarlatto; e poi di nuovo alleggerimenti rosati che digràdano verso una forma, inaspettata, di ìndaco: e vìa di nuovo a agitare arcobaleni cangianti che, nel cuore pieno della sua distrazione, lo riportano alle labbra di lei ogni volta che se le ricorda.
Quando Dio inciampa – questo, dall’episodio dell’orecchio – èvita di nominarsi.
Allora si ferma, inspìra e respìra dando preterintenzionalmente vita a tre quattro dimensioni nascoste. Si raccoglie in Sé – creandone inaspettatamente un’altra – e cerca di non pensare.
Le ultime Voragini Inconsapevoli della Sezione GD della Fascia Nera oltre i quasar di Qhb’nhm’b si sono create così.
Quando Dio non pensa, gli Universi ripòsano.
Ora ha deciso di distogliere l’attenzione dalle Immagini di Lei che gli s’accàlcano nel punto più geloso e segreto che Si vede dentro – ci fosse mai un dentro – e intorno (ci fosse mai un intorno). Ma la Visione – le Visioni – di Lei s’infiltrano nelle porzioni di sogno che si concede quando è particolarmente stanco. Si stanca apposta – rifinire una Nebulosa, ripristinare i recinti di azoto e idrogeno intorno alle Esplosioni meno riuscite degli ultimi undici bigbang – ma non gli basta mai. C’è sempre un momento eterno di lucidità – “Quanto dura un momento?”, poi – che gli s’impone: rinfacciàndogli le troppe parole; le troppe paure immateriali (Lui stesso fàtica a definirsi l’immaterialità) che l’hanno perseguitato.
Se Dio ha paura, la Paura è Dio.
E quando Dio se ne dimentica, sono cazzi.
(Quest’ultima espressione, Dio l’ha imparata in un Tempo Incerto che gli appare, verde e scintillante, nei Sogni di quando si ricrea prima del tempo mentre lo crea).
Lei non lo desidera. Lei non lo ama. Questo si scandisce dentro in continuazione, oscillando con i pensieri da un momento all’altro della Disperazione – quando Dio si dispera, gli Universi si fermano con un fruscìo – e intanto si prefigura il modo – perché il modo c’è, dovrebbe solo capirlo e sincronizzare le forme di amore che fluttuano― il modo di affiancarsi a Lei e di smetterla, con le parole. Trovare questa naturalezza – dopotutto è stato lui il primo a trovarla, la natura degli Universi che li riguardano – tutta quella facilità con cui Lui e Lei si sono trovati l’Uno nell’Altra, l’Una nell’Altro: come se l’Universo fosse fuoco liquido che aspettava di fonderli insieme in un’Eternità distinta di differenze che si esaltano l’Una dell’Altra; l’Una nell’Altra.
Quando Dio usa troppe parole, le parole si perdono Dio.
Troppe paturnie, probabilmente, si dice. Usando un’espressione che gli sembra di aver carpìto da qualche universo in bianco e nero già formato.
Non Le può imporre di amarlo nel modo che vorrebbe Lui. E in questo modo ha momentaneamente impedito – “Sì, ma quanto dura un momento?” – di potersi amare, Lui e Lei, nel modo che li avrebbe resi sempre felici. Li renderebbe felici. Li renderà felici. Felici.
Ha davvero pensato questa parola? Il ridicolo stopposo della Verità a rigargli i contorni del presente eterno che lo invade.
(Quando Dio pensa troppo, c’è il rischio che le parole diventino troppo pesanti).
Quanto è riduttivo, si dice, affidare a una manciata di suoni – esplosivi o liquidi non conta – la Realtà quando la crediamo.
Il silenzio, si dice. Quanto l’Estremo Silenzio dei Giorni in cui Lei, e Lui, semplicemente si sono ritrovati (ché quando c’è un Silenzio che unisce Lui e Lei tra gli Universi e le parole non servono, e non bastano, non c’è se non ritrovamento: quasi i Tempi e il Tempo non fossero che una danza circolare, e eterna, in cui il guizzo dissacrante del magico accordo, la risata rossa che incastra Lui, e Lei, in un tempo comune e in un unico bàttito biunivoco, in un algoritmo mutevole, diventano la scoperta ripetuta dell’esserci un Lui, e una Lei).
Ogni tanto Dio pensa che non sia il caso di fare Dio, poi si ricorda di esserlo.
Così.
Oggi Dio ha deciso di coltivare il suo giardino. Un’illuminazione che gli ha suggerito Lei un giorno; e a cui lui ha immediatamente aderito come se fosse l’unica cosa sensata da fare. Si dedica all’Albero al centro modificandolo a ogni pensiero; un tronco nodoso e mobile che prima si lascia frastornare dal vento galattico che gli sìbila intorno, poi muta forma, sbiadisce, si ricrea inscatolandosi in chiaroscuri che lo delineano, e delìmitano, stagliandosi nel netto poroso della luce ghiaccia degli Universi attorno (ci fosse davvero un attorno).
Dio fatica intorno all’aiuola che gli si sgretola fumosa tra i piedi e le mani. Gli piace la stanchezza che questo gli procura, l’attenzione particolare che deve concedere allo stillare di acqua dalle mani per dare aiuto alle piante del giardino. L’albero si trasforma a ogni colpo di pneuma dal petto; ora è più un cespuglio di rose, i petali screziati che a poco a poco si fanno rossi, poi rosa, investendo di nuovo il futuro della loro specie. In colori maiformati che si manifestano nell’attimo stesso in cui dilàvano, storditi, smemorati, in sfumature nuove.
Ogni volta che lavora in questo modo Dio si chiede se l’odore che lo avvolge per secoli-luce e formazioni di nubi di elio primitive dipenda da lui o no; se sia sudore, o no; si chiede se invece non sia un ristagno corale fatto di fatiche malpagate, povertà, speranze insensate, lavori di ristrutturazione, polvere di eoni dimenticati, amori perduti come conchiglie, o stelle marine, fatte di calcare e ossido di carbonio. Tutte categorie che prima o poi si dovrà prendere la briga di inventare, se gli resterà il tempo.
Dio non riesce a abituarsi al dolore. Gli sembra un torto che non gli rende Giustizia.
Mentre lavora, le mani sporche di una qualche terra incerta, l’acqua che scende a torrenti come fosse olio dal capo di Aaron – anche se non ha ancora deciso chi sia, Aaron – e dalle dita si depòsita, prestigiatrice e accaldata, tra le radici e i fiori: mentre lavora si chiede se lasciarla uscire dagli occhi potrebbe aiutarlo o no, quella stessa acqua che ora usa per accudire i fiori, e le piante, in questo Giardino al centro dell’Universo, sospeso come un terrazzino interno su un garage senz’auto; largo quanto la memoria di tutte le umanità che lo proseguiranno, se avrà la fortuna di pensarci da Sé. Acque dagli Occhi che si spalàncano in muraglie liquide e lasciano fuggire dalla prigionia tutti i dolori, la terra lontana e promessa di una qualche salvezza dal dolore cui non possa sfuggire neppure Dio, se Lei non vuole.
Le Sue dita sfiorano belle di notte, bocche di leone. Fiori luminosi e bellissimi che il futuro trasformerà in frutti. Il fico, prima, l’assurdità reticente del terrore della nudità, poi la mela: la polpa della mela a sfaldare il retaggio primitivo dei fiori che sta assistendo, amorevole, mentre Lei è lontana, e adesso neanche Dio saprebbe dire dov’è – “Ma quanto dura un momento?” – in questo momento.
Che assurdità, dice a Sé Stesso, preferire un frutto qualsiasi alla Bellezza momentanea e quotidiana di questi fiori. Preferiranno ricordare una colpa, Si dice. Quando qui e ora – sapesse davvero anche Lui che cosa sono il qui e l’ora – c’è soltanto la luce, e la grazia, di questi fiori che si sporgono al tempo come la sfida più fragile, e bella, che lui possa affrontare.
In questi fiori mi sono riconosciuto, si dice. E loro lo chiameranno peccato.
Peccato. Non lo capiranno, lo fraintenderanno. Sviseranno sconsideratamente sulla sua natura di spreco; ma di questo sta parlando, Dio, le lacrime finalmente agli occhi, gli occhi pensati per l’occasione: l’occasione di non lasciare le lacrime prive di forze.
Che spreco pensa. Che peccato.
E che ridìcole, le lacrime, ogni volta, tutte le volte. Ridicole come gli esseri umani, si dice.
O peggio.
Ridìcole come Me.
Non può continuare. Continuerà.
Come gli ha spiegato un qualchedio di cui ha solo una vaga impressione. C’è ancora il Tempo che serve, Si dice.
Ora che lo lasciamo per un momento da solo, Dio sta pensando ai suoi fiori.
L'articolo Free Will For Free proviene da minima&moralia.











.jpg)